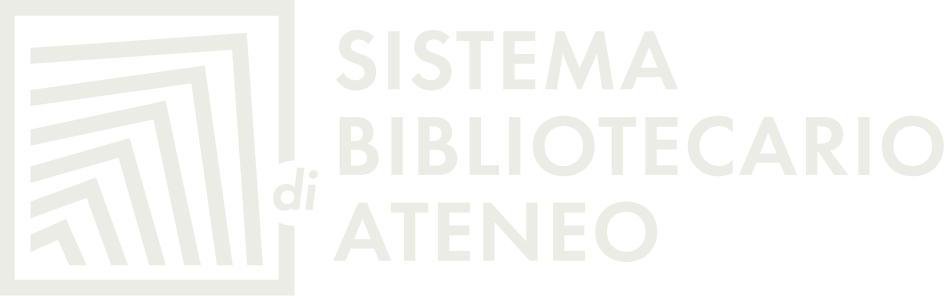Tesi etd-01202022-192717 |
Link copiato negli appunti
Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
BORRELLI, ILARIA
URN
etd-01202022-192717
Titolo
Il contributo della sociologia visuale nello studio dei margini
Dipartimento
SCIENZE POLITICHE
Corso di studi
SOCIOLOGIA E MANAGEMENT DEI SERVIZI SOCIALI
Relatori
relatore Prof.ssa Paone, Sonia
Parole chiave
- border
- boundary
- fotografia
- indagine
- margine
- periferia
- perspective
- photography
- prospettiva
- sociologia visuale
- survey
- visual sociology
Data inizio appello
21/02/2022
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
21/02/2092
Riassunto
Al di là del dibattito sorto circa trent’anni fa intorno alla sociologia visuale, dopo decenni di intrecci tormentati, dai contorni sfumati, a tutt’oggi soprattutto in Italia non c’è ancora chiarezza sul rapporto tra fotografia e sociologia e su cosa sia la sociologia visuale. Nate entrambe alla fine dell’Ottocento, entrambe con il fine di “esplorare la società”, fotografia e sociologia hanno preferito per un lungo periodo affiancarsi a discipline ritenute più affini. Dal canto suo, la fotografia ha peccato di essere sempre stata considerata ciò che non si richiedeva che fosse: troppo oggettiva e semplicisticamente meccanica per essere considerata una forma d’arte come la pittura, non sufficientemente analitica e troppo polisemica per essere utilizzata come strumento d’indagine da parte di una neonata sociologia alla ricerca del proprio riconoscimento come disciplina scientifica.
Questo suo “status ambivalente” di nuova forma d’arte e al tempo stesso documento scientifico, ha creato dubbi e incertezza sulla legittimità del mezzo, che persistono tutt’ora. Negli anni Ottanta il dibattito si è spostato sulla presunta contraffazione digitale operata dall’immagine computerizzata: la possibilità di alterare digitalmente una foto con la manipolazione dei pixel quanto a colore, luminosità e messa a fuoco avrebbe infatti distrutto la sua condizione sine qua non, che qualcosa cioè sia davanti alla lente quando avviene lo scatto, al di là dei possibili dubbi sulla sua autenticità.
Una polemica che risulta sterile e fuorviante se prendiamo in considerazione diversi fattori.
Innanzitutto, tutta la realtà nel suo complesso è una costruzione sociale, culturale e situata: viviamo la realtà quotidiana come un mondo intersoggettivo, mediato, filtrato e modificato dal contesto socio-culturale che abbiamo interiorizzato nell’identità assegnata.
In secondo luogo, viviamo nella cosiddetta società dell’immagine in cui l’esperienza visuale non è più circoscritta a determinati contesti ma è centrale perché si tende a visualizzare tutto, e ciò caratterizza quella che è stata definita “cultura visuale” come “strumento per interpretare il mondo visivamente”. Il passaggio dalla modernità alla post-modernità ha corrisposto difatti a quello dal testo all’immagine nel processo di costruzione dei significati e delle relazioni sociali, e come modalità di rappresentazione del mondo. Tuttavia, la comunicazione per immagini, che siano analogiche o computerizzate, è per sua stessa natura polisemica, cioè capace di generare molti significati e interpretazioni. Per quanto riguarda la fotografia, ciò è collegato prima di tutto alla sua natura simbolica come mezzo di comunicazione dotato di un codice debole; in secondo luogo, alla complessa relazione che c’è tra gli elementi che la compongono. Il significato della fotografia cioè è costruito da chi la fa e da chi la vede, i quali portano entrambi la loro posizione sociale, i loro interessi, la loro soggettività, così che il suo significato cambia nei differenti contesti di produzione e visione.
Fotografare avrebbe quindi un particolare carattere di selezione, ritaglio di un’area delimitata del reale, e ciò ha un significato sociologico fondamentale. Si tratta di un mezzo espressivo trasversale, che coglie un attimo di tempo e lo cristallizza, eternizzando il movimento di cui quell’attimo è portatore; un’istantanea che ritaglia una porzione di realtà, tecnicamente definita dall’inquadratura (lo zoom varia il campo visuale, un grandangolo altera i rapporti spaziali fra gli oggetti) e rielaborata oggi con la postproduzione; un fermo-immagine, capace di farci vedere il mondo con occhi nuovi. Le macchine fotografiche iniziarono infatti a duplicare il mondo nel momento stesso in cui il paesaggio cominciava a cambiare a un ritmo vertiginoso; era il congegno capace di registrare ciò che stava scomparendo (rioni sventrati, luoghi rurali sfigurati).
Riassumendo, se pensiamo per immagini e le immagini contengono pensiero, se visualizzare significa rendere visibile nel senso di mostrare, fornire una definizione della realtà, una visione del mondo, e la visualizzazione avviene sempre all’interno di una cultura, di un insieme cioè di pratiche di produzione e scambio di significati, la visione è quindi sempre un’interpretazione, frutto di un percorso storico, culturalmente strutturato, soggettivo (in riferimento al contenuto denotativo dell’immagine) e situato (condizionato dal contesto di fruizione). E fare fotografie significa filtrare, creare un percorso significativo, fare affermazioni selettive sulla realtà in un contesto di possibilità date all’individuo da cultura, sistema valoriale, esperienze passate, progetti futuri. Dunque, da una parte vediamo e quindi accettiamo e significhiamo solo quello che possiamo vedere, e quindi categorizzare e controllare; dall’altra il mondo che vediamo è quello che qualcuno ha scelto di mostrarci. Ne consegue un relativismo culturale (esistono modi alternativi di visione) e la necessità di un processo di negoziazione interpersonale e/o interculturale (mettersi cioè nei panni dell’altro e assumerne lo sguardo), perché diversi modi di vedere un’immagine ne modificheranno gli effetti. Appare dunque prioritario spostare la riflessione sulla necessità di un’alfabetizzazione visiva atta a fornirci un codice interpretativo per riconoscere il significato connotativo di un’immagine e saper cogliere i cambiamenti nella visione portati dalla tecnologia verso l’affermazione di una sociologia visuale più consapevole di esserlo.
Ciò consente di indagare luoghi e realtà, quelle marginali nella fattispecie, da una prospettiva diversa, alla scoperta dello sguardo culturale che si nasconde dietro l’obiettivo e dietro certe rappresentazioni iconografiche oltre che linguistiche della marginalità, e come tali rappresentazioni possano rafforzare una certa stigmatizzazione, fino ad una sorta di interiorizzazione e cristallizzazione di tale processo, in quella che spesso si configura come una profezia che si autoadempie. La “consapevolezza del contesto” infatti porta a concepire centro e margine come punti di vista, determinati da certe posizioni all’interno di un dato spazio sociale, e lo stigma come una prospettiva di un “processo sociale a due, assai complesso”. Guardando così al margine come a un’entità che non esiste di per sé come autonoma e omogenea ma derivante da dinamiche causali contraddistintive, con matrice storica, modalità sociali e forme esperienziali specifiche a seconda del contesto, assume particolare importanza l’analisi del processo di connotazione di luoghi e gruppi sociali come realtà marginali anche in Italia.
In conclusione, questo “viaggio” attraverso l’analisi dei saggi di autori quali Arnheim, Mirzoeff, McLuhan, Sontag, Freund, passando per Bourdieu, Goffman, Barthes fino a Becker, Harper, Faccioli, Losacco, Mattioli, Ferrarotti, cerca di mostrare come la fotografia possa rappresentare uno strumento sociologico prezioso e come ciò possa risultare particolarmente rilevante per l’affermazione di una sociologia visuale che possa essere anche capace di andare oltre i luoghi comuni veicolati tramite l’uso di un certo linguaggio anche iconografico.
Riprendendo le parole di Forgacs (2015, Intro, pp. XI, XXI, XXII), “i margini non sono equiparabili a un mero fatto di natura. Sono prodotti da determinati modi di vedere e di organizzare lo spazio sociale”; e ancora “l’atto di denominare [e, aggiungo, rappresentare] un luogo come margine è accompagnato spesso da una reale pratica spaziale di segregazione o espulsione. Il luogo va a coincidere con il nome. E’ la realizzazione in senso letterale [e, aggiungo, visiva] di un’idea di esclusione sociale”: all’interno di tali processi “sono incorporate sempre relazioni di potere. Chi possiede e punta l’obiettivo che fotografa queste persone?”.
Questo suo “status ambivalente” di nuova forma d’arte e al tempo stesso documento scientifico, ha creato dubbi e incertezza sulla legittimità del mezzo, che persistono tutt’ora. Negli anni Ottanta il dibattito si è spostato sulla presunta contraffazione digitale operata dall’immagine computerizzata: la possibilità di alterare digitalmente una foto con la manipolazione dei pixel quanto a colore, luminosità e messa a fuoco avrebbe infatti distrutto la sua condizione sine qua non, che qualcosa cioè sia davanti alla lente quando avviene lo scatto, al di là dei possibili dubbi sulla sua autenticità.
Una polemica che risulta sterile e fuorviante se prendiamo in considerazione diversi fattori.
Innanzitutto, tutta la realtà nel suo complesso è una costruzione sociale, culturale e situata: viviamo la realtà quotidiana come un mondo intersoggettivo, mediato, filtrato e modificato dal contesto socio-culturale che abbiamo interiorizzato nell’identità assegnata.
In secondo luogo, viviamo nella cosiddetta società dell’immagine in cui l’esperienza visuale non è più circoscritta a determinati contesti ma è centrale perché si tende a visualizzare tutto, e ciò caratterizza quella che è stata definita “cultura visuale” come “strumento per interpretare il mondo visivamente”. Il passaggio dalla modernità alla post-modernità ha corrisposto difatti a quello dal testo all’immagine nel processo di costruzione dei significati e delle relazioni sociali, e come modalità di rappresentazione del mondo. Tuttavia, la comunicazione per immagini, che siano analogiche o computerizzate, è per sua stessa natura polisemica, cioè capace di generare molti significati e interpretazioni. Per quanto riguarda la fotografia, ciò è collegato prima di tutto alla sua natura simbolica come mezzo di comunicazione dotato di un codice debole; in secondo luogo, alla complessa relazione che c’è tra gli elementi che la compongono. Il significato della fotografia cioè è costruito da chi la fa e da chi la vede, i quali portano entrambi la loro posizione sociale, i loro interessi, la loro soggettività, così che il suo significato cambia nei differenti contesti di produzione e visione.
Fotografare avrebbe quindi un particolare carattere di selezione, ritaglio di un’area delimitata del reale, e ciò ha un significato sociologico fondamentale. Si tratta di un mezzo espressivo trasversale, che coglie un attimo di tempo e lo cristallizza, eternizzando il movimento di cui quell’attimo è portatore; un’istantanea che ritaglia una porzione di realtà, tecnicamente definita dall’inquadratura (lo zoom varia il campo visuale, un grandangolo altera i rapporti spaziali fra gli oggetti) e rielaborata oggi con la postproduzione; un fermo-immagine, capace di farci vedere il mondo con occhi nuovi. Le macchine fotografiche iniziarono infatti a duplicare il mondo nel momento stesso in cui il paesaggio cominciava a cambiare a un ritmo vertiginoso; era il congegno capace di registrare ciò che stava scomparendo (rioni sventrati, luoghi rurali sfigurati).
Riassumendo, se pensiamo per immagini e le immagini contengono pensiero, se visualizzare significa rendere visibile nel senso di mostrare, fornire una definizione della realtà, una visione del mondo, e la visualizzazione avviene sempre all’interno di una cultura, di un insieme cioè di pratiche di produzione e scambio di significati, la visione è quindi sempre un’interpretazione, frutto di un percorso storico, culturalmente strutturato, soggettivo (in riferimento al contenuto denotativo dell’immagine) e situato (condizionato dal contesto di fruizione). E fare fotografie significa filtrare, creare un percorso significativo, fare affermazioni selettive sulla realtà in un contesto di possibilità date all’individuo da cultura, sistema valoriale, esperienze passate, progetti futuri. Dunque, da una parte vediamo e quindi accettiamo e significhiamo solo quello che possiamo vedere, e quindi categorizzare e controllare; dall’altra il mondo che vediamo è quello che qualcuno ha scelto di mostrarci. Ne consegue un relativismo culturale (esistono modi alternativi di visione) e la necessità di un processo di negoziazione interpersonale e/o interculturale (mettersi cioè nei panni dell’altro e assumerne lo sguardo), perché diversi modi di vedere un’immagine ne modificheranno gli effetti. Appare dunque prioritario spostare la riflessione sulla necessità di un’alfabetizzazione visiva atta a fornirci un codice interpretativo per riconoscere il significato connotativo di un’immagine e saper cogliere i cambiamenti nella visione portati dalla tecnologia verso l’affermazione di una sociologia visuale più consapevole di esserlo.
Ciò consente di indagare luoghi e realtà, quelle marginali nella fattispecie, da una prospettiva diversa, alla scoperta dello sguardo culturale che si nasconde dietro l’obiettivo e dietro certe rappresentazioni iconografiche oltre che linguistiche della marginalità, e come tali rappresentazioni possano rafforzare una certa stigmatizzazione, fino ad una sorta di interiorizzazione e cristallizzazione di tale processo, in quella che spesso si configura come una profezia che si autoadempie. La “consapevolezza del contesto” infatti porta a concepire centro e margine come punti di vista, determinati da certe posizioni all’interno di un dato spazio sociale, e lo stigma come una prospettiva di un “processo sociale a due, assai complesso”. Guardando così al margine come a un’entità che non esiste di per sé come autonoma e omogenea ma derivante da dinamiche causali contraddistintive, con matrice storica, modalità sociali e forme esperienziali specifiche a seconda del contesto, assume particolare importanza l’analisi del processo di connotazione di luoghi e gruppi sociali come realtà marginali anche in Italia.
In conclusione, questo “viaggio” attraverso l’analisi dei saggi di autori quali Arnheim, Mirzoeff, McLuhan, Sontag, Freund, passando per Bourdieu, Goffman, Barthes fino a Becker, Harper, Faccioli, Losacco, Mattioli, Ferrarotti, cerca di mostrare come la fotografia possa rappresentare uno strumento sociologico prezioso e come ciò possa risultare particolarmente rilevante per l’affermazione di una sociologia visuale che possa essere anche capace di andare oltre i luoghi comuni veicolati tramite l’uso di un certo linguaggio anche iconografico.
Riprendendo le parole di Forgacs (2015, Intro, pp. XI, XXI, XXII), “i margini non sono equiparabili a un mero fatto di natura. Sono prodotti da determinati modi di vedere e di organizzare lo spazio sociale”; e ancora “l’atto di denominare [e, aggiungo, rappresentare] un luogo come margine è accompagnato spesso da una reale pratica spaziale di segregazione o espulsione. Il luogo va a coincidere con il nome. E’ la realizzazione in senso letterale [e, aggiungo, visiva] di un’idea di esclusione sociale”: all’interno di tali processi “sono incorporate sempre relazioni di potere. Chi possiede e punta l’obiettivo che fotografa queste persone?”.
File
| Nome file | Dimensione |
|---|---|
Tesi non consultabile. |
|